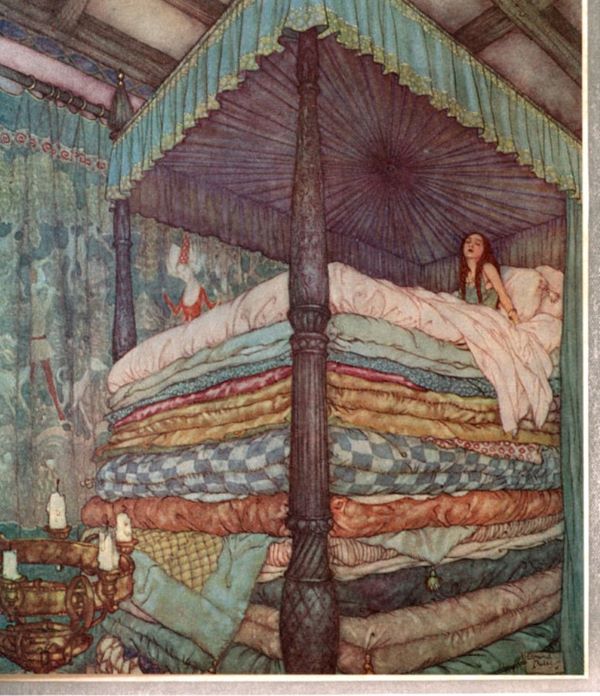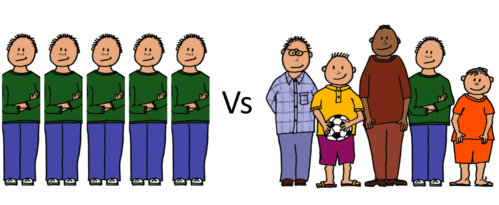I termini “farmaco” e “medicinale” (e anche “prodotto medicinale”) non sono la stessa cosa, anche se sono stati usati nel corso degli anni come sinonimi; di recente si è preferito usare il termine medicinale, che viene impiegato anche nelle direttive comunitarie che disciplinano questo settore.
Citiamo testualmente dal sito salute.gov:
Si intende per medicinale:
- ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane;
- ogni sostanza o associazione di sostanze che possa essere utilizzata sull’uomo o somministrata all’uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica.
Sempre sul detto sito si specifica che “tutti i medicinali sono costituiti da principi attivi e da vari eccipienti. Il principio attivo è il componente dei medicinali da cui dipende la sua azione curativa, il medicinale vero e proprio.
Gli eccipienti sono invece componenti inattivi del medicinale, privi di ogni azione farmacologica”.
E, ancora, si precisa che i medicinali possono distinguersi in: medicinali preparati in farmacia (galenici, a loro volta suddivisi in magistrali [se preparati in base a una prescrizione medica destinata a un determinato paziente]; eofficinali [se preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea europea o della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana e destinati ad essere forniti direttamente ai pazienti serviti da tale farmacia) e medicinali di origine industriale. L’immissione in commercio di questi ultimi deve essere autorizzata dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) o dall’Agenzia Europea per i medicinali (EMEA).
Il medicinale generico, invece, è un medicinale che è bioequivalente rispetto a un medicinale di riferimento, con brevetto scaduto, autorizzato con la stessa composizione quali-quantitativa in principi attivi, la stessa forma farmaceutica, la stessa via di somministrazione e le stesse indicazioni terapeutiche. Tuttavia, il termine “generico”, si è dimostrato infelice in quanto percepito dal pubblico come simile, ma non uguale al medicinale di riferimento indicato per la stessa patologia. Per questa ragione i prodotti “generici” sono stati ridefiniti medicinali equivalenti (L. 149 del 26 luglio 2005).
Fonte:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3615&area=farmaci&menu=med